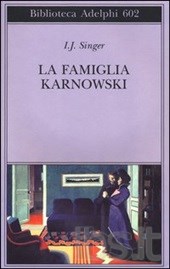 (Titolo originale Di mishpohe Karnovski, 1943)
(Titolo originale Di mishpohe Karnovski, 1943)
Trad. Anna Linda Callow, Adelphi Ed., collana Biblioteca Adelphi, 2013, pp. 498, €.20
“Come si dice, l’ebreo è impuro, ma i suoi soldi sono kasher” (Solomon Burak)
“Gli occhi appannati del ragazzo si spalancarono e diventarono più azzurri. Davanti a loro si sovrapponevano due immagini…..
Provò un violento moto di disgusto insieme a una rabbia furibonda e a una sensazione di forza nelle mani, come alla vista di un orribile animale strisciante”
Provò un violento moto di disgusto insieme a una rabbia furibonda e a una sensazione di forza nelle mani, come alla vista di un orribile animale strisciante”
A settant’anni dall’uscita a New York in lingua originale (yiddish, poiché il testo in inglese apparve assai più tardi), dopo la versione francese ad opera di Monique Charbonnel per le edizioni Denoël & Ailleurs (2008), finalmente, grazie alla Casa Editrice Adelphi ,alla sua responsabile di ebraistica Elisabetta Zevi e alla vissuta traduzione di Anna Linda Callow, Docente di Lingua e Letteratura Ebraica all’Università di Milano, anche il pubblico italiano può conoscere ed amare questo romanzo, davvero un cuneo che l’autore “con la penna insinua nella chiusa personalità dei lettori”, secondo un’efficace affermazione di Elias Canetti, ricordato da Gianfranco Ravasi nel suo Breviario settimanale sull’inserto domenicale de il Sole 24 Ore del 2 giugno scorso.
La Famiglia Karnowski di Israel Joshua Singer è un’opera / mondo nella quale ci si avventura seguendo svariati percorsi e tematiche -uno per tutti: l’antisemitismo europeo nelle sue diverse forme e sfumature-; un’affascinante, drammatica rappresentazione che ci racconta le storie di tre generazioni di Ebrei: dalla natìa, tradizionale Polonia di fine Ottocento alla moderna Berlino, dapprima della, sia pur ingannevole, integrazione, indi del nazismo; fino alla durissima New York della salvezza e dell’esilio; nella perenne ricerca di un equilibrio, molto difficile da realizzarsi, tra identità ed assimilazione.
La lettura è scorrevole, coinvolgente, anche perché inserita in un ambito storico ben preciso. Nulla quindi a che vedere con certe opere -non rare oggi- prolisse e fredde, in primo luogo perché intimiste e del tutto decontestualizzate.
Infatti il volume è pure un “raro documento di immenso valore storico per ricostruire la vita delle comunità ebraiche distrutte dalla follìa nazista”, come osserva da ultimo, in un breve commento sulle pagine di cronaca locale de il Corriere della Sera, Romano Montroni -illustre libraio bolognese, pieno di quello spirito di iniziativa che gli viene dal grande amore per la cultura autentica-.
Indispensabile un inquadramento, sia pur sintetico, dell’Autore nell’ambito, in primo luogo, del suo contesto familiare.
“Dedico queste pagine alla memoria del mio defunto fratello, I.J. Singer, autore dei Fratelli Ashkenazi. Egli era per me non soltanto il fratello maggiore, ma anche un padre spirituale e veramente un maestro di vita. Io guardo a lui come a un modello di grande spiritualità e di probità letteraria”. Con tali parole l’insigne Autore polacco, naturalizzato statunitense, scrittore in lingua yiddish, Isaac Bashevis Singer (1902/1991), Premio Nobel per la letteratura 1978, dedica il suo La Famiglia Moskat(1950) al fratello maggiore di undici anni, Israel Joshua, nato nel 1893 e morto d’infarto a cinquantun’anni.
Quando era già da tempo noto in tutto il mondo, Isaac Bashevis soleva affermare, a proposito di Israel Joshua: “Sto ancora imparando da lui e dalla sua opera”.
Davvero una famiglia eccezionale, i Singer. I genitori, il Rabbino (e autore di commentari) Pinchas Meindl Zinger e Basheva Zylberman, a sua volta figlia di un rabbino hassidico di Bilgoraj, ebbero quattro figli: la primogenita, Esther, fu valente scrittrice a sua volta, ma misconosciuta dall’ambiente tradizionale che la voleva sacrificata, in quanto donna, nelle sue aspirazioni culturali; seguivano tre maschi, Israel Joshua, Isaac Bashevis -in omaggio alla madre, appunto Basheva- e Moshe, l’unico non scrittore, morto nel 1946.
Dopo i primi anni di vita e l’adolescenza passate nel quartiere popolare ebraico di Varsavia dove il padre teneva il suo tribunale rabbinico, Israel, considerato a lungo il “genio di famiglia”, aveva lasciato quell’ambiente tradizionale ed abbracciato la Haskalah, l’illuminismo ebraico. In patria aveva pure studiato pittura, ma ben presto sentì nascere in sé la vocazione letteraria. Nel 1918, suggestionato dalla Rivoluzione bolscevica, si recò in Russia, dove aderì ad un gruppo di scrittori radicali yiddish, il Circolo di Kiev, e cominciò a pubblicare i primi racconti. Disgustato per l’antisemitismo che sperava fosse scomparso grazie alla nuova situazione politica, tre anni dopo ritornò a Varsavia, dove continuò la sua attività letteraria e iniziò a collaborare con Forward, il celebre quotidiano yiddish di New York. Sulle colonne del giornale apparvero articoli aspramente critici verso l’Unione Sovietica, che gli valsero l’ostilità dell’ambiente comunista cui aveva in precedenza aderito. Decise allora di partire per gli USA, dove, alcuni anni dopo, arrivò il fratello minore Isaac (il quale, a sua volta, iniziò a scrivere per Forward).
Una meritata fama lo raggiunse; non a caso, tanti anni dopo, l’illustre critico letterario statunitense Harold Bloom, in un’intervista datata 2009, ha dichiarato che, tra i due fratelli Singer, il più dotato non è il Premio Nobel Isaac, ma il meno noto, al contemporaneo pubblico dei lettori, Israel Joshua [1].
Purtroppo, proprio all’indomani dell’uscita de La famiglia Karnowski, Israel morì all’improvviso. Per le paradossali vicende dell’esistenza egli entrerà in una sorta di cono d’ombra, mentre inizierà l’ascesa del fratello minore.
Occorre tener presente un aspetto nell’opera di Israel J. Singer.
Egli non ci parla direttamente della Shoah perché si spegne prima che essa sia conosciuta nella sua completezza; ma ne ha un’intuizione, rendendocela così -forse- ancora più terribile. Quel vuoto, quel “non detto”, quei riferimenti a “laggiù” ti toccano il cuore. Che fine avrà fatto, ad esempio, Rebecca, la sorella minore di David Karnowski, rimasta a Berlino, contrariamente ai suoi parenti emigrati all’estero, per non allontanarsi dal marito, un mediocre musicista convinto di poter finalmente emergere dopo che i suoi colleghi, più abili e famosi di lui, intuendo il pericolo, hanno lasciato la Germania?
Lo stesso sentimento di vuoto, di desolazione che ti coglie oggi allorché ti rechi, nella capitale tedesca, allo Jüdiches Museum, ideato da Daniel Libeskind ed inaugurato ufficialmente nel 2001, ma visitabile, nelle sue strutture, fin da alcuni anni prima.
Uno dei luoghi più emblematici della città.

*****
Il nostro romanzo è suddiviso in tre parti, ciascuna dedicata ad un personaggio della famiglia, colui intorno al quale ruota il racconto: David; Georg; Jegor.
Indimenticabile l’inizio che inquadra i Karnowski “della grande Polonia”, affidabili -pur non facoltosi- commercianti di legname, studiosi di Talmud e di altri sacri testi; nonché di materie profane, quali la filosofia e la matematica, ed affamati lettori di libri in lingua tedesca.
Personaggi liberi, ben consapevoli delle loro qualità, ai quali sta stretto l’ambiente religioso ed ultratradizionale dello shtetl di Melnitz.
E infatti il polemico rampollo di casa, David, “raffinato purista della grammatica ebraica”, dapprima litiga aspramente, in occasione della sua presentazione in sinagoga, col rabbino locale perché sorpreso a leggere -orrore!- il Pentateuco commentato da Moses Mendelssohn (1729/1786), il fondatore della Haskalah; indi prende l’irrevocabile decisione di andarsene, con la giovane moglie Lea, nata Milner (figlia, a sua volta, di un ricco commerciante di legname), da quel luogo di “selvaggi e bifolchi” verso la patria della ragione e dei lumi, la città che, fin da adolescente, lo aveva attratto in modo irresistibile, cioè Berlino. Via, via dalle…tenebre dell’arretratezza!
L’Autore ha arricchito questo personaggio con diversi aspetti della propria esperienza giovanile. Nessuno riesce a fermare David, men che mai i suoceri, costernati all’idea di separarsi dall’amata figlia.
Nella nuova patria egli si ambienta molto bene: parla un perfetto tedesco, ha successo nell’attività commerciale, diviene una figura di rilievo in città e, grazie alla sua cultura, stringe rapporti, anche istituzionali, con i membri della Nuova Sinagoga, quella sulla Oranienburgerstraße per capirci. Costoro non sono “immigrati miserabili, appena giunti dall’Est, ma la crema della società ebraica, radicata nel paese da molte generazioni”. Non hanno cioè nulla a che vedere con i residenti sulla Dragonerstraße, quelle persone che si ostinano a parlare yiddish e non sanno esprimersi in corretto tedesco. Allorché, dopo tre anni di matrimonio, alla coppia nasce un figlio, gli vengono imposti due nomi: Moshe, in memoria certo di Mendelssohn, ma pure il nome ebraico con il quale sarebbe stato chiamato, nel giorno del bar mitzvah, a leggere il testo sacro in sinagoga; e Georg, il nome tedesco, a ricordo di quello del nonno paterno (Gershom), da usare nella vita quotidiana. Tutto questo in omaggio all’aurea massima, ribadita il giorno della circoncisione del piccolo: “Sii ebreo a casa tua, ma un uomo [cioè un tedesco, in nulla diverso dagli altri] quando ne esci”.
Se David ha trovato la sua strada, non si può dire altrettanto di Lea. La giovane si sente una straniera in un contesto tanto diverso da quello in cui è cresciuta, cioè l’ambiente caldo, familiare di Melnitz, lasciato così a malincuore. Fatica a imparare la nuova lingua, nonostante i perentori inviti del coniuge a smettere di parlare quel dialettaccio da ignoranti che è lo yiddish ed esprimersi finalmente nella lingua della Germania; le celebrazioni religiose a Berlino le sembrano fredde, lontane; e perfino le tenerezze, che il marito le sussurra ora tra le lenzuola, le appaiono prive di passione. E le signore dell’alta società, moglie del rabbino in testa, ma non solo, la mettono terribilmente a disagio.
Ella si consola parlando con il figlioletto nell’idioma di casa, chiamandolo col diminutivo di Moysele; anche se, ben presto, questi impara a correggerla stizzito: “Io non sono Moysele, sono Georg!”.
Ma soprattutto fonte di gioia per Lea sono le visite che ella compie, allorché gli affari spingono David lontano da casa, all’Emporio delle Occasioni di Solomon Burak, posto sulla Landsberger Allee, a poca distanza dallo Scheunenviertel, la zona abitata da ebrei galiziani e polacchi, cioè il quartiere dei fienili, così chiamato perché ivi, alcuni secoli addietro, vennero costruiti i fienili nel rispetto di un decreto che proibiva di immagazzinare nel centro cittadino materiali infiammabili, quali il fieno e la paglia.
Solomon, chiamato Shloymele dalla moglie Ita, è, a sua volta, un immigrato da Melnitz, abbandonata da giovanissimo, diversi anni prima, per andare a fare il venditore ambulante nei paesini tedeschi, con un fagotto di mercanzia appresso.
Ma, al contrario di Karnowski, non ha affatto rinnegato le proprie origini, ci mancherebbe!
Il negozietto dell’inizio sulla Linienstraße è stato rimpiazzato dall’enorme magazzino dove Burak concentra le ingenti quantità di merci che acquista a basso costo: articoli di fine serie, giacenze dopo fallimenti o incendi, tutto ciò che è a buon mercato. Ottiene credito dalle banche, in quanto operatore affidabile.
La clientela è costituita per lo più da gentili, attratti dai prezzi convenienti, ma anche da quegli ebrei, residenti nel Paese da tanto tempo, i quali peraltro non gradiscono affatto che si rammenti loro, tra un acquisto e l’altro, donde vengono. Invece Solomon glielo ricorda ad ogni pié sospinto, con ogni mezzo, diretto e indiretto: dal suo nome ebraico che spicca a chiari caratteri sull’insegna, al personale impiegato, tutto rigorosamente importato da Melnitz, alle espressioni in lingua originale sciorinate, senza alcun problema, davanti a tanta gente; ebrei o meno, non conta.
Eh sì, perché il Sig. Burak sa benissimo che i goym, alla fin fine, in cuor loro (e chi per un motivo, chi per un altro), detestano tutti gli ebrei, indipendentemente dal numero di anni di residenza sul suolo tedesco, dalle apparenze, dal linguaggio forbito. Essi, gratta gratta, sono considerati alla stessa stregua di quelli ritratti dalla vignettistica tradizionale: il sempiterno Ebreo, der ewige Jude (espressione tanto cara ai Nazisti), con la palandrana, il sacco di masserizie sempre in spalla e magari i cernecchi ai lati del volto. La Storia, tanti anni dopo, gli darà drammaticamente ragione.
Il nostro furbo mercante, poi, non si adonta per i modi sprezzanti con i quali viene trattato dai correligionari della Oranienburgerstraße. Piuttosto si piglia gioco di loro, sia pure in modo benevolo perché non perde mai il sorriso. “Che cosa fa il tacchino di Pesach?…Fa sempre la ruota?” chiede sarcastico a Lea alludendo al marito di lei. A nulla valgono le occhiatacce di Ita, la quale cerca di rimediare alle intemperanze del coniuge offrendo all’amica di riguardo nella sua casa, sempre aperta a chiunque, ciambelline, dolcetti al papavero, biscotti al miele….I profumi e i sapori della Galizia, che gioia per gli occhi e il palato!
Georg cresce secondo i desideri paterni; ma, nonostante l’impegno di David, i coetanei vedono in lui soprattutto l’ebreo, a cominciare da coloro che risiedono nello stesso palazzo, tutti gentili. Ma il ragazzo matura nel tempo una volontà di ferro e, dopo la prima giovinezza scioperata e un inizio inconcludente di studi filosofici, si iscrive alla Facoltà di Medicina. In parte per vocazione sincera, in parte per spirito di concorrenza verso la prima (e forse unica) passione amorosa della sua vita: Elsa Landau, affascinante dottoressa, figlia di un medico vegetariano convinto, un tipo bizzarro, di nome Fritz, ma di gran cuore e competenza, tutto dedito ai suoi pazienti del quartiere operaio di Neukölln; unico ebreo tra goym privi di pregiudizi e colmi di gratitudine per lui. Padre e figlia formano un duo affiatato, spesso in polemica, ma legati da profondo affetto. Anche la bella Elsa dalla lunga chioma rossa è attratta da Georg, ma è tutta concentrata dapprima sulle ricerche mediche, indi divorata dal demone dell’ambizione politica. Diventa ben presto deputata di sinistra al Reichstag, è inseguita dalla stampa; e, per motivi opposti, dagli avversari politici conservatori, i quali non sopportano che una donna -per di più giovane, di gradevole aspetto e, addirittura!, ebrea- occupi un posto di riguardo. E, col passare del tempo, altri nemici, ben più pericolosi, cercheranno di insidiarla.
Non c’è quindi posto, nella vita di lei, per un marito ed una famiglia. Elsa peraltro si affaccia, qua e là nel romanzo, con il suo incrollabile coraggio fisico e morale.
Benché articolato secondo una linea maschile, il romanzo ci dona pure stupende figure femminili; Elsa è tra queste, così come, per motivi diversi, Lea, simbolo della tenerezza ostinata.
Allorché scoppia il primo conflitto mondiale Georg si arruola, quale medico militare, sul fronte orientale e si batte con coraggio, come tanti ebrei, ai quali, negli anni successivi, la patria volgerà le spalle col più atroce dei tradimenti. I terribili ricordi dei campi di battaglia resteranno impressi nel giovane per sempre.
Il dopoguerra segna la rapida affermazione professionale del Dr. Karnowski, il quale diventa, in pochi anni, il più famoso ginecologo di Berlino, direttore di una rinomata clinica sulla Kaiser Allee. In ospedale conosce una timida e sensibile infermiera, Teresa Holbek; attratto dalla sua dolcezza e dedizione, Georg incomincia a frequentarla con assiduità. Ciò porta non poco trambusto nelle rispettive famiglie d’origine: gli Holbek sono cristiani, con una precisa opinione nei confronti degli Ebrei: “…sentivano gli ebrei estranei, li classificavano tra le persone poco affidabili, come gli attori, che si possono ammirare, ma dai quali è sempre bene stare lontani”.
Teresa è una specie di Lea in versione cristiana. La moglie tradizionale, che tuttavia, all’occorrenza, sa essere forte e decisa.
David Karnowski, dal canto suo, è fuori di sé. Per quanto integrato nella società tedesca, è per lui inconcepibile che il primogenito esca con una shikse, termine dispregiativo yiddish per “non ebrea”. E poi aver rifiutato i ricchi partiti che gli venivano offerti a vantaggio di una semplice infermiera è davvero inconcepibile! Georg non intende ragione e sposa Teresa, rompendo i ponti col padre (ma la madre non lo abbandona). Ammirato dalle pazienti per la competenza e l’indubbio fascino personale, è invitato alle serate mondane della capitale.
In proposito davvero gustosi sono i quadretti dedicati da Singer al salotto dell’editore Rudolf Moser (un ebreo convertito) dove si riunisce “la crema della città: poeti d’avanguardia, attori ed attrici famosi, corrispondenti dei grandi giornali esteri, deputati, musicisti….chiunque sia un personaggio in vista”. Totale libertà di abbigliamento e…..di condotta.
Al centro dell’attenzione la moglie (non ebrea) di Moser, un’autentica “mangia-uomini”, la quale, fin dall’ingresso in casa sua della coppia Karnowski, si dà da fare per sedurre il celebre e carismatico chirurgo, va da sé sotto gli occhi della moglie di lui. E, sia pure per un breve lasso di tempo, ci riesce. “Non è bella, nulla di paragonabile a Teresa. La nuca, sotto i capelli tagliati corti, è rigida e mascolina. Ha occhi da felino grigi e sornioni e una bocca dalla piega risoluta, sarcastica. Anche la sua figura non è aggraziata come quella di Teresa. La gambe sono troppo muscolose….Ma tutto il suo corpo teso trabocca di un ardore selvaggio. Da donna sensuale ed esperta, [nel ballo] si avvolge intorno a lui come un serpente, lo lascia un istante per poi riacciuffarlo più stretto…”.
Ma sotto la cenere dell’apparenza spumeggiante e spensierata, tipica della Repubblica di Weimar, cova un fuoco che porterà a tragiche conseguenze. La crisi postbellica del 1922/1924 e la tremenda inflazione che seguì alla chiusura degli stabilimenti della Ruhr; il fallito putsch nazista di Monaco del novembre 1923, conclusosi con l’arresto di Adolf Hitler -che, in carcere, scrive il suo programma politico, cioè il Mein Kampf-; l’uscita dalla prigione dopo soli nove mesi (in realtà era stato condannato a cinque anni di detenzione), la trionfale, irresistibile ascesa nel periodo successivo, delle camicie brune e del loro indiscusso capo. Senza contare l’altra, indimenticata, crisi finanziaria, quella del 1929.
Tempi bui si preparano per gli Ebrei. In modo inesorabile, lento, ma non troppo, si moltiplicano le violenze e le aggressioni ai loro danni. Singer dipinge con colori foschi e con frasi efficacissime quel clima di “tensione indefinita…un misto di attesa, esaltazione, paura, quando gli uomini in stivali [i nazisti, è chiaro] s’impadronirono delle strade e delle piazze”.
“Dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale e la costituzione della repubblica di Weimar, un complesso di idee definite come nazionalpatriottiche o völkisch, cioè legate al Volk, s’impose a livello popolare”. Non a caso il principale giornale nazista era il Voelkischer Beobachter, cioè l’Osservatore del Popolo. “Il termine Volk, popolo, racchiudeva in sé un significato pregnante, quello di un insieme di individui legati da un’essenza trascendente che poteva essere la natura, il cosmo, il mito. Gli autori nazionalpatriottici ritenevano che l’animo del Volk fosse influenzato dalla natura del paesaggio. Gli ebrei, considerati ancora gente del deserto…venivano giudicati…incapaci di profondità di pensiero, mentre i tedeschi, figli di foreste oscure e nebbiose, più di ogni altro aspiravano alla luce e potevano essere definiti Lichtmenschen…Gli ebrei erano considerati estranei…guardati con sospetto e anche con timore. Antropologia, eugenetica e pensiero sociale ormai andavano di pari passo, anche se non ancora a passo dell’oca” [2].
Gli uomini del “nuovo ordine” marciano e urlano a squarciagola: “ Quando il sangue ebraico zampilla dal coltello, allora tutto va di nuovo così bene, così bene” (“Wenn das Judenblut vom Messer spritz, dann geht’s noch mal so gut, so gut”). E spesso non si tratta di disadattati o poveri, ma di giovani istruiti di buona famiglia. I terroristi hanno un volto comune, in tutte le epoche ed i contesti, si sa. Ieri come oggi.
Tanti, tra gli Ebrei, specie coloro che risiedono in Germania da secoli, cercano di non dare importanza a ciò che sta accadendo, ritengono (o fanno finta di ritenere) che queste agghiaccianti novità non riguardino loro, integrati da sempre nel tessuto sociale; ma l’angoscia e il terrore sono palpabili ovunque.
Paradossi dell’esistenza, fa notare a David un anziano e coltissimo libraio, Efraim Walder, una delle poche persone residenti sulla Dragonerstraße cui egli si degni di far visita: “…volevamo essere ebrei in casa e uomini in strada, è arrivata la vita e ha messo tutto sottosopra: siamo goym in casa ed ebrei in strada”.

A queste gravi preoccupazioni se ne aggiunge un’altra per Georg e Teresa, non meno dolorosa. Dal loro matrimonio è nato un figlio, chiamato Georg -come il padre- Joachim -dal nome del defunto nonno materno-, detto ben presto Jegor.
Fin dalla più tenera età il ragazzo subisce l’influenza della famiglia materna, dove, da una parte, la nonna gli propina, forse quasi senza rendersene conto, i triti luoghi comuni dell’antigiudaismo cristiano; dall’altra, con rara perfidia, lo zio Hugo, fratello di Teresa, un debosciato fanatico di uniformi, marce e quant’altro (sedicente valoroso soldato nella guerra che ha visto la Germania sconfitta dai “traditori”), sostenitore dei nuovi padroni del Paese, gli fa un vero e proprio lavaggio del cervello, instillandogli odio antisemita, che porta Jegor, sensibilissimo e psicologicamente instabile come molti coetanei, a rifiutare la parte ebraica di sé. Rifiuto che, per assurdo (ma è un’assurdità apparente, se ci si pensa bene), tocca il culmine allorché egli viene denudato a forza su un podio, nel teatro della sua scuola, di fronte, non solo ai compagni di classe, ma a tutti gli studenti, al corpo insegnante ed altre autorità, poiché il preside, l’ottuso Prof. Kirchenmeyer, decide di mostrarlo come modello vivente delle nuove teorie razziali, come espressione del “cattivo influsso della razza negro-semitica su quella nordica quando si uniscono”.
Jegor ne esce traumatizzato. Conseguenza devastante e, come detto, all’apparenza incomprensibile: odio irrefrenabile verso il padre e tutti gli Ebrei, unito ad un’attrazione fatale nei confronti degli uomini che marciano, marciano, tanti cari a suo zio. “…SA marschiert, mit ruhen festen tritt” , così l’inno delle S.A. naziste (le cosiddette Camicie brune, i gruppi paramilitari), chiamato Horst Wessel Lied: “La SA marcia con passo calmo e sicuro”.
Anche a causa di tale tragica situazione, per togliere i congiunti da quell’aria ammorbata che sta per ucciderli nell’anima e nel corpo, Georg si dà da fare per ottenere, a sé e ai suoi, un visto di espatrio, finché ciò è possibile. Destinazione: gli USA. Nella speranza che, al di là dell’oceano, il figlio ritrovi se stesso.
La terza parte del libro, dedicata a Jegor, è, a mio parere, la più avvincente, anche se, confesso, talvolta ho avuto la tentazione di interromperne la lettura, tanto quelle pagine grondano sofferenza. Se si ha però l’animo di proseguire e giungere alla fine, ci si rende conto quanto La Famiglia Karnowski sia un autentico romanzo di formazione, anzitutto per il lettore.
Inoltre non mancano notizie di carattere storico/politico a proposito della diffusione nel mondo della piovra nazista, che riusciva a raggiungere con i suoi tentacoli anche i Paesi democratici.
Lascio quindi a chi legge la sorpresa di scoprire pian piano questo “viaggio di conversione” in America dei Karnowski, insolita, profonda Teshuvah (in ebraico תשובה, letteralmente “Ritorno”), che tocca, secondo corde diverse, i membri della Famiglia, anche in un rapporto rinnovato proprio con quelle persone che, nella precedente esistenza di “laggiù”, erano state trattate con freddezza ed alterigia.
Ma è il giovanissimo Karnowski il perno della vicenda. Dopo una discesa agl’inferi, che è quanto di più orribile ed inimmaginabile si possa concepire, ha il coraggio di riprendersi la propria umanità, sia pure a prezzo di un gesto estremo. Commoventi le pagine finali, Padre e Figlio che si ritrovano. Saranno la Speranza e la Vita a vincere, dopo la disperazione e la morte del dolore.
[1] Tra le numerose recensioni a questo romanzo segnalo, per tutte, quella a firma Nicoletta Tiliacos, su il Foglio di sabato 11 maggio 2013, cui mi sono ispirata per le notizie biografiche sull’Autore.
[2] Così Riccardo CALIMANI nel saggio Capitali europee dell’Ebraismo tra Ottocento e Novecento, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, Settembre 1998, pp. 216; v. alla voce Ebrei e tedeschi a Berlino, p. 171.
